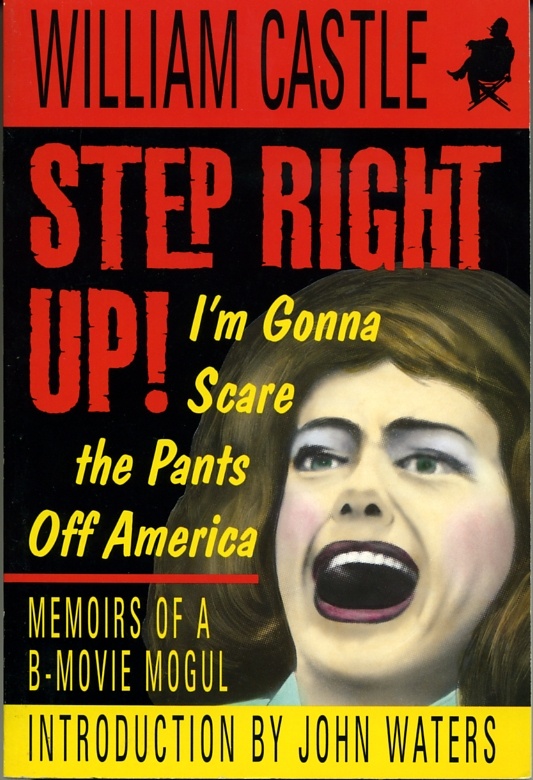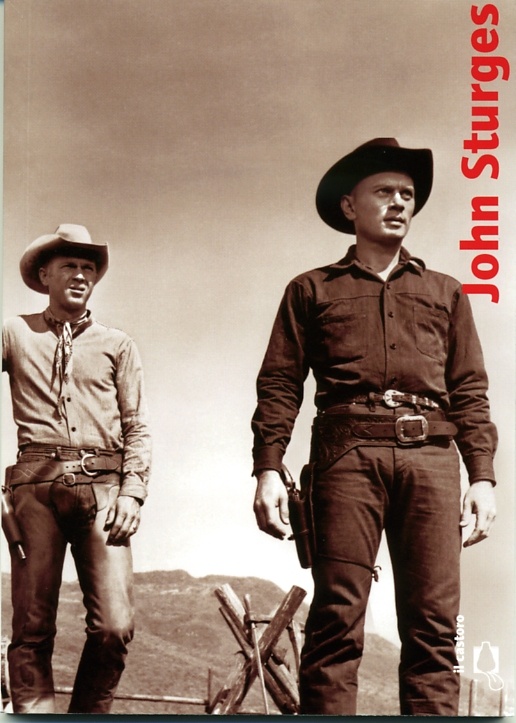Dopo un film di Julie Taymor viene voglia di mettersi a dieta per qualche giorno: vedere, per un po’, film in bianco e nero, rigorosi piani sequenza, minimalismo, silenzio, non oltre gli ottanta minuti che erano la norma qualche decennio fa, quando il cinema non era ancora obbligato a strappare gli spettatori alla programmazione televisiva.
Però, come avviene con certi cenoni familiari nelle occasioni importanti, ogni tanto una bella scorpacciata bisogna pur farsela, e un film come “Across the Universe” è un’occasione più che discreta per tornarsene a casa barcollando, alla ricerca di un bicchiere di bicarbonato visivo.
La Taymor è una provocatrice barocca che viene dal teatro (e ci torna spesso e volentieri) e che, come spesso accade ai registi di derivazione teatrale quando impugnano la macchina da presa, si scatena nell’esplorazione forsennata di tutti i mezzi che il teatro non offre. In misura minore e modi diversi è quel che è successo, soprattutto nei primi film, a Mike Nichols (e, più di recente, a Sam Mendes e perfino
al nostro Fausto Paravidino), solo che la Taymor sembra aver intenzione di rilanciare di film in film, così che “Across the Universe” è stilisticamente ancora più radicale di “Frida”, che a sua volta esasperava le tendenze all’eccesso che erano già evidenti in “Titus”.
In qualche modo, l’eccesso viene qui in parte giustificato dal genere cui il film appartiene: “Across the Universe” è a tutti gli effetti un musical, costruito su un’ampia scelta di canzoni dei Beatles utilizzate intere o in frammenti, di volta in volta per sostituire una o più battute di dialogo, per reggere un’intera scena, o anche semplicemente per rappresentare un numero musicale che fa parte della narrazione. Il musical è per sua natura un genere a stilizzazione marcata, sia che ci si sbizzarisca nel montaggio sia che ci si valga di coreografie elaborate, sia, infine, che ci si affidi agli artisti della composizione digitale per combinare l’uno e l’altro con le regole e le potenzialità dell’animazione.
Se un problema c’è, è nel materiale di partenza: partendo da Shakespeare o dalla biografia di un personaggio interessante come Frida Kahlo, la Taymor disponeva di basi molto solide su cui costruire le più immaginose stiribaccole visive. Ma i Beatles sono materiale molto più difficile: estrapolate dal loro contesto, le canzoni sono, spesso, solo canzonette e illustrarle in modo significativo non è affatto scontato. È probabilmente per questo che la Taymor ha ambientato il film nell’epoca della contestazione, di Timothy Leary, degli hippies e del flower power, imbastendo la storia dell’amore fra un ragazzo di Liverpool di estrazione proletaria e una fanciulla dell’America benestante, benpensante e benenata.
Ma non basta: le immagini e nuovi arrangiamenti riescono a dare qualche spessore in più ad alcune canzoni d’amore, però poi il film procede per la sua strada senza sviluppare i temi a cui accenna: l’incipit di “Girl” annuncia un amore che si rivelerà molto meno tormentato di quanto non sembri promettere (e non può che ricordare l’apertura del pur sopravvalutato “Moulin Rouge”, che il suo bel po’ po’ di dramma in serbo ce l’aveva), “Something” anticipa la separazione fra i due amanti in un momento che si direbbe prematuro. E “I Want To Hold Your Hand”, resa particolarmente tenera da un contesto omosessuale, introduce un tema che lì, semplicemente, si esaurisce.
“Across the Universe” è un po’ tutto così: funziona bene finché si tratta di descrivere un clima, ma inciampa ogni volta che accenna a voler alzare il tiro, con numeri musicali che esprimono la promessa di un qualcosa senza che il resto del film si senta obbligato a mantenerla. C’è un bellissimo balletto sulla visita di leva dei giovani da spedire in Vietnam, ma la provocazione rimane visiva e si spegne sull’ultima nota. Il grande conflitto fra i due protagonisti si risolve nel fatto che lei decide di impegnarsi a fondo nella protesta, mentre lui si chiude nella sua ricerca artistica e diventa geloso della “causa” che impegna la fidanzata. E quando alla fine, dopo il Vietnam, gli arresti e le sparatorie sugli studenti, questo amore mica tanto contrastato si chiude in bellezza con un grande abbraccio, per giunta sulle note di “All You Need Is Love”, l’impressione è che la Taymor abbia scelto la via più facile, mettendo su un’antologia beatlesiana che ricorda certi greatest hits prodotti dalle case discografiche in vena di strenne di facile smercio, senza minimamente porsi il problema di ricavarne un concept album.
È un limite importante, che forse spiega l’accoglienza nel complesso non entusiasmante che il film ha ricevuto da parte di alcuni critici. Eppure non si può negare che “Across the Universe” resti nonostante tutto uno spettacolo generoso, defatigante in modo piacevole, strapieno di idee, di colori e, ovviamente, di musica. Con un paio di partecipazioni straordinarie che dovrebbero essere apprezzate da chi conosce meglio di me il mondo del rock (ma anche no: ho sentito i recensori del gradevole podcast Filmspotting lamentare che l’apparizione di Bono sia quasi offensiva, e che la presenza di Joe Cocker abbia come unico risultato quello di far risaltare quanto i protagonisti, per quanto talentosi, non siano vocalmente all’altezza di cantanti veri e propri).
Alla Festa del Cinema di Roma, la sala era entusiasta: il ritmo del numero musicale che chiude il film è stato accompagnato tutto dagli applausi, che hanno proseguito lungo tutti i titoli di coda e si sono prolungati per altri cinque minuti a schermo spento, con la Taymor e gli altri membri del cast che si godevano il trionfo. Vedremo se le cose andranno altrettanto bene nelle sale, ma per apprezzare come merita “Across the Universe” è consigliabile dare prima una piccola sfoltita alle proprie aspettative.